In questi giorni sono lontana dalla mia città. Siamo in campagna. In vacanza.
In qualche modo protetti da quella che amici e parenti mi dicono essere un’atmosfera surreale, una città chiusa in un silenzio assordante, intervallato dal suono delle sirene e dal rumore degli elicotteri in volo.
Per chi non era su quel ponte, ma nelle sue vicinanze, tutto è iniziato con un grande botto, di quelli di cui lì per lì non capisci il senso.
Cosa sarà mai successo, ti chiedi?
Non immagini di certo, che a crollare sia stato il ponte Morandì, quello che chiunque nella tua città, potrebbe percorrere in ogni momento: per andare a lavorare, per tornare a casa, per andare in vacanza… il ponte di Brooklyn dei Genovesi.
Ed erano persone che stavano facendo tutte queste cose, quelle che non ci sono più.
Da quella maledetta mattina, quella in cui alla fine, siamo stati miracolati, non faccio altro che immaginare la mattina di tutte quelle persone che, senza saperlo, andavano incontro alla parola fine.
Non posso smettere di immaginarlo, perché la loro mattina poteva essere una mia stessa mattina. Quella della partenza per le vacanze, dopo aver caricato le valigie, piena di aspettative per le giornate che sarebbero arrivate.
Quella in cui nonostante tutto, vai a lavorare, anche se è la vigilia di ferragosto, il tempo è orribile e tu te ne saresti stato a casa.
No, non riesco a non pensarci. Non riesco a non sentire una fitta tremenda al cuore.
Quel ponte è crollato
Due giorni dopo, averlo percorso per l’ultima volta, con il timore nel cuore, il mio, che potesse crollare proprio mentre passavamo.
Non avevo mai fatto un pensiero simile. Chissà forse, nemmeno chi quella maledetta mattina, si è trovato lì sopra, inghiottito dal vuoto.
Un tempo tremendo, a Genova si stava scatenando l’ira di Dio, che sapeva, sarebbe accaduto qualcosa di grave e non per mano sua.
Da quel giorno, Genova e i Genovesi non sono più gli stessi: qualcosa è cambiato per sempre.
Quel ponte, per me, era la via verso casa, quando si tornava dalle vacanze: quel cartello rallentare posto a inizio galleria, lo preannunciava ogni volta.
Da lì, potevo rivedere la scritta Bon Jour sulla collina di fronte e immaginare la casa dei miei, che è subito lì sotto. Da lì, potevo scorgere l’insegna IKEA e quel grattacielo la cui forma, ogni volta, mi ricordava quella di un tronky. Quando salivo su di esso, sentivo aria di casa e, anche se ritornare dalle vacanze non era il massimo, rivedere quelle immagini familiari, era come abbracciare di nuovo una persona cara.
Quel ponte era la strada verso la mia libertà di ragazza, lo percorrevo ogni notte per uscire con le mie amiche, che abitavano dall’altra parte della città. Le prime volte con la patente, lo squillo a mia mamma quando ero arrivata a destinazione.
Quel ponte era la strada verso il mio posto di lavoro, quando la mattina presto lo percorrevo per poi, rientrare la sera.
Quel ponte era l’inizio di tanti viaggi
E ora, che sono qui a prendermi i baci di mia figlia, a prendermi gli abbracci di mio figlio, a guardare il mio compagno, ad abbracciare i miei genitori, a dir loro vi voglio bene, ho il magone.
In realtà ce l’ho da giorni, quattro per la precisione.
Perché sono quattro i giorni che sono passati da quando quel ponte, è crollato portando giù con sè, a oggi, 41 vite.
Famiglie intere, bambini, papà, amici, lavoratori, ragazzi. Tutti risucchiati in quel vuoto e schiacciati da un ponte che si è sbriciolato su di loro.
Non si può sentire, non si può leggere, non si può immaginare che nel 2018 si possa morire per questo.
Sto male da giorni, da quattro giorni che, in realtà sembrano un tempo molto più lungo.
E mi sento in colpa.
Ogni momento che vivo, penso a tutte quelle persone che ora non vivono più.
Lo so, che colpa ne ho alla fine io? Non l’ho fatto crollare io e nemmeno, potevo sapere sarebbe accaduto.
Già, non ne ho.
Eppure passo queste giornate immaginando che, mentre io sono qui a pensare a cosa faremo questo pomeriggio, ci sono persone che scavano ininterrottamente sotto quelle macerie. Ci sono famiglie distrutte che piangono i loro cari, ci sono figli che non hanno più un papà.
Mi sento in colpa, perché sono qui, invece che nella mia città a dare una mano, ma nello stesso tempo, non so se avrei la forza di farlo.
Allora, il minimo che posso fare, è piangere, stare male, provare empatia per tutte quelle persone.
Il mio dolore resta comunque, piccolo se paragonato a chi ha perso i propri cari.
E finalmente stamattina l’ho fatto, ho pianto, ho pianto tantissimo, nascosta in cucina vicino al frigorifero.
Perché oggi, potevo esserci io in quella bara, perché poteva esserci qualcuno dei miei cari. Perché non ci doveva essere nessuno oggi, lì dentro.
Non si può morire così.
No, non si può.
E il vuoto che ha lasciatot, quel buco, che ha liberato il panorama dal cemento, mi ricorda una sola certezza: la vita è davvero un susseguirsi di “adesso”.

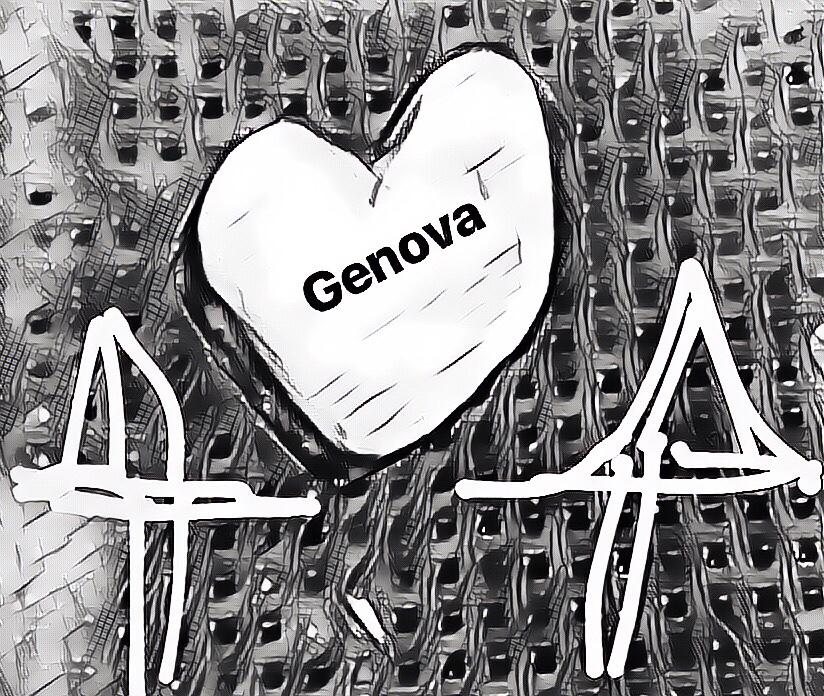


Hai scritto proprio quello che provo anche io da giorni. È terribile, non possono accadere cose simili.
La mia Genova, la nostra Genova. Ancora una volta in silenzio. Ancora una volta senza parole.
L’atmosfera qui è pesante. È come se tutto si fosse trasformato in cristallo.
E sembra strano passare davanti a quel ponte, vedere che manca un pezzo e pensare a quante volte ci siamo tutti passati.
Hai spiegato tutto alla perfezione e scritto benissimo come sempre.
Un abbraccio.
Guarda io mi sento male al pensiero di rientrare… sono giorni che non posso fare a meno di pensarci, mi vedo scorrere il volto di quel bambino, di quelle famiglie, di quelle povere persone. Tutto di cristallo, hai reso benissimo… io stento a crederci, come sia possibile tutto ciò. Grazie per le tue parole, la condivisione, il buttare fuori, aiuta molto a elaborare, anche se il dolore resta. Un abbraccio grande da Genivese, mamma e donna.